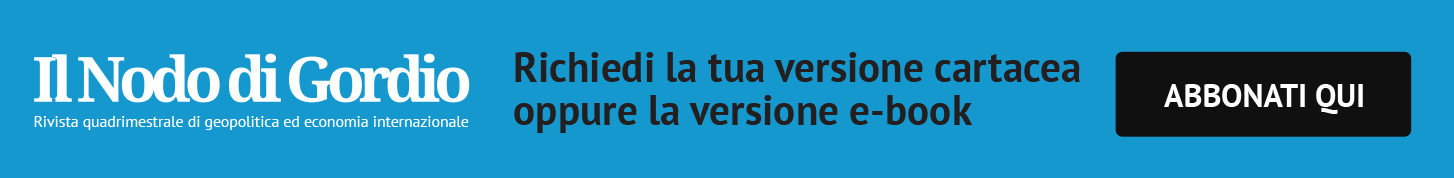Sono rientrato pochi giorni fa dalla Serbia, dove mi trovavo per coprire l’emergenza rifugiati, sul confine serbo-macedone, precisamente nella località di Presevo.
“Sono solo un fotogiornalista” è ciò che rispondevo, in inglese, a chi, tra quei pochi che lo parlano, era in coda per ottenere la carta di permesso per lasciare il paese. Mi chiedevano aiuto, mostrandomi i loro figli piccoli in braccio e chiedendomi di poter uscire dalla folla. Questa spingeva e si accalcava, ciecamente, come un corpo unico, privo della razionalità dei suoi singoli individui, guadagnando ad ogni passo un metro in più verso l’ingresso del centro d’identificazione.
Questa coda era delimitata da una cortina continua di transenne presiedute dalla polizia e successivamente anche dall’esercito, che distribuiva il “plasma” umano all’interno, attraverso percorsi di incanalamento divisi in compartimenti, secondo gli stessi criteri utilizzati dai pastori durante le operazioni di tosatura del gregge.
Il giorno che sono arrivato pioveva e ha continuato a piovere incessantemente anche nei giorni successivi. La gente aspettava in coda diverse ore, anche venti o più, stanca, affamata, assonnata, con i piedi nel fango e i propri bagagli al seguito. Le uniche protezioni, fornite dalle scarse istituzioni presenti, erano poncii e teli di plastica che coprivano a tratti la coda, mentre pochi fortunati si riparavano sotto il proprio ombrello.
C’era caos ovunque, reso più acuto anche dalle pessime condizioni atmosferiche e dal flusso continuo di persone. Ne arrivavano anche dieci mila nell’arco delle ventiquattr’ore.
Tutto si svolge, lungo una strada periferica di questo piccolo villaggio che è Presevo, nei pressi della stazione ferroviaria. Un chilometro circa di lunghezza sulla quale i rifugiati arrivano dal vicino valico di frontiera con la Macedonia. Chi a piedi, chi con gli autobus, da Miratovac raggiungono l’inizio di questa strada parzialmente chiusa e il cui flusso viene gestito dalla polizia; incamminandosi quindi verso il Centro di identificazione e registrazione dove viene rilasciato il foglio di via per poter lasciare la Serbia (entro un tempo limite di 72h a partire dal rilascio, superato il quale subentra l’obbligo di dover richiedere asilo in Serbia).
Il centro è di sola identificazione e registrazione ed eventuale assistenza medica in caso di necessità, con Doctors Without Borders e la Croce Rossa Serba (con un ruolo non troppo ben specificato) che insieme all’UNHCR, responsabile delle operazioni nel centro insieme al Ministero dell’Interno serbo, sono le uniche istituzioni presenti in loco. Non ho visto nessun’altra ONG internazionale, le uniche associazioni di volontari erano straniere e purtroppo piccole e quindi prive di mezzi adeguati, nonostante il lodevole impegno e la presenza costante.
La strada è come un piccolo centro abitato isolato dal resto del paese e purtroppo salvo pochissimi residenti, la maggior parte di questi si è rivelata fondamentalmente fredda e inospitale ma altrettanto falsamente cortese al momento di vendere loro qualcosa.
La situazione che va avanti da oltre tre mesi ormai, ha probabilmente logorato e stancato gli abitanti di questa piccola comunità, il cui atteggiamento comunque non giustificato, penso sia dovuto e rivolto non tanto ai rifugiati, quanto alla pressoché totale assenza delle istituzioni e al fatto che l’Europa se ne sia completamente lavata le mani, lasciando la Serbia in balia di se stessa. Una nazione che, nonostante abbia lasciato alle proprie spalle la guerra da ormai vent’anni, fatica ancora oggi ad affermare la propria identità socio-economica nell’assetto geopolitico europeo, spingendo i suoi abitanti ad emigrare come gli stessi rifugiati. Ad esasperare ulteriormente, è il conflitto etnico presente sul territorio. Nello specifico, Presevo è una comunità per il 90% di etnia albanese, che subisce per questo, un trattamento discriminatorio da parte delle istituzioni (di etnia serba), come, ad esempio: l’assenza di un ospedale o altra struttura sanitaria (quello più vicino si trova a 30km di distanza), o che venga negata loro la possibilità di lavorare in quanto albanesi.
Pertanto, i suddetti abitanti, non hanno fatto altro che reagire allo status quo; approfittando della situazione e creando un business sull’esodo, finché dura… Del resto lo stesso è stato fatto un po’ ovunque, dal Medio Oriente al “ricco” Occidente.
I rifugiati, infatti, ad oggi non ricevono né cibo, né acqua, ne tende; devono quindi acquistare tutto sul posto. Chi non possiede una tenda di proprietà, acquistata magari durante le tappe precedenti, passa la notte dove può in ripari di fortuna come scantinati di case in costruzione, anfratti, e stanze messe a disposizione illegalmente dai residenti a pagamento e contro la legge serba che vieta l’accoglienza di rifugiati senza permesso. Infine, resta solo la terra e il fango ad accogliere su teli di plastica le stanche membra degli “ultimi”.
Gli Organi statuali competenti avrebbero dovuto creare un vero e proprio corridoio umanitario continuo, dalla Grecia all’Europa centrale, senza lasciare ai singoli paesi attraversati la dubbia e improvvisata gestione di un fenomeno demografico così importante. La Serbia è uno di questi paesi, che si è trovato a dover affrontare autonomamente qualcosa cui la stessa Europa non era preparata, senza aver oltretutto alcuna disponibilità di mezzi per poterlo fare in modo dignitoso.
Infatti, è l’assenza di dignità la cosa più evidente a Presevo, nelle immagini che ho avuto davanti agli occhi quasi tutto il tempo. Una dignità venuta meno forse più negli occhi di chi guarda, vergognandosi della situazione, che in quelli degli “attori” del grande esodo.
Insieme ad una collega americana di origini libanesi, abbiamo cercato di aiutare soccorrendo il più possibile, quando si è potuto, sfruttando il proprio ruolo “neutrale” e relativo “potere” riconosciuto da polizia ed esercito. Posti di fronte a situazioni che non potevano essere ignorate e sollecitati da richieste pressanti di aiuto, quello che abbiamo fatto è stata comunque poca cosa rispetto a ciò che si sarebbe potuto fare.
Una corretta ed efficace gestione richiedeva: più volontari, interpreti, distribuzione di pasti caldi e tende dove dormire, nel rispetto della dignità della persona umana presente.
È mancata una completa informazione, attraverso cartelli in arabo, farsi, urdu, inglese, lungo il percorso. Oltre alla stanchezza e alla fame si aggiungeva lo smarrimento derivante dal non sapere…cosa fare una volta arrivati? Evidentemente ogni frontiera ha le sue regole organizzative e strategiche, ma nel caos queste diventano ancor meno visibili. Per questo abbiamo attivato lo strumento del “passaparola”, soprattutto per evitare che incappassero anche nei trucchi della malavita locale come i taxi illegali per il trasporto di persone senza permesso a Belgrado o a Sid verso il confine con la Croazia, per cifre astronomiche. Oppure chi, vicino ai bus, unico mezzo a disposizione per raggiungere la frontiera successiva, vendeva falsi permessi a 20 € l’uno, a chi stanco di aspettare voleva andarsene. Quando questo si è verificato, interi viaggi sono stati annullati con il relativo ritorno dell’autobus al punto di partenza e con il conseguente obbligo di ri-pagamento regolare del viaggio corrispondente a 35 € a persona anche da parte di coloro che erano stati rispettosi delle regole poste. Tali bus erano gestiti da compagnie private o da padroncini del mezzo, che percorrevano notte e giorno la tratta avanti e indietro da sud a nord trasportando a turno i rifugiati come Caronte da una sponda all’altra della Serbia.
La scena grottesca era rappresentata da alcuni ragazzini, assoldati come procacciatori d’affari dagli autisti dei bus stessi, che appostandosi all’uscita dal Centro, offrivano ai rifugiati posti a sedere in autobus con una modalità quasi fosse cosa illecita. Il rifugiato, pur conscio dell’irregolarità di tale modalità, accettava nella consapevolezza dell’unica alternativa possibile per raggiungere il confine croato proseguendo il proprio cammino.
Non so come evolverà adesso la situazione, in funzione anche dei delicati equilibri dipendenti dall’apertura e chiusura dei vari confini, ma continuano ad arrivare migliaia di persone quotidianamente. Se non interverrà “qualcuno”, inviando sul posto aiuti umanitari, più volontari, mezzi e strumenti idonei, le condizioni non potranno che peggiorare con l’arrivo dell’inverno alle porte.
Gianfranco Gallucci (1981) vive a Roma e lavora come fotografo documentarista indipendente.
Coinvolto per lo più in progetti a lungo termine, si occupa di immigrazione e tematiche legate al territorio, società e cultura, esplorando le relazioni intercorrenti tra noi e i luoghi in cui viviamo. Collabora con riviste italiane e straniere e i suoi lavori sono stati esposti in gallerie e musei come la Triennale di Milano e il museo MACRO di Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA