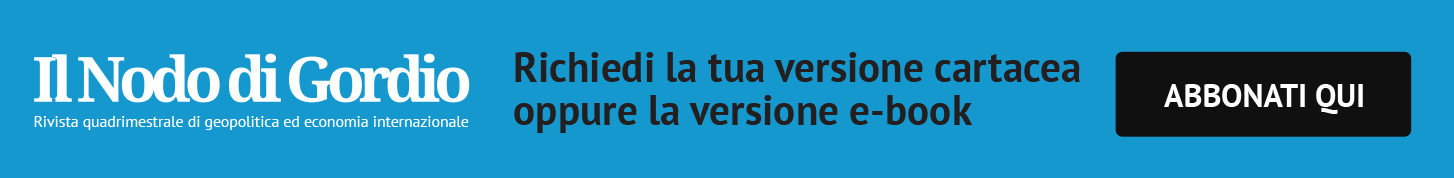Ebbene, sì.
Ci sono caduto, quel lunedì primo aprile (non a caso, il giorno del “Pesce”…), nella trappola tesa da quel buontempone un po’ iconoclasta un po’ macabro che mise in giro – credo a partire dalla solita Wikipedia – la balla di un Jacques le Goff autore, tra le millanta cose della sua sterminata bibliografia, anche di un racconto di genere fantasy. In fondo, mi sta bene: chi di spada ferisce eccetera… Appartengo difatti alla sconsiderata, allegra genìa di quelli che talvolta si sono divertiti a inventarsi falsi autori e falsi titoli di cronaca o di trattato medievali per vedere quanti austeri colleghi ci cascavano e facevano circolare la goliardica panzana. Di questi scherzi mancini le cronache accademiche sono piene: mi pare che a suo tempo ci si sia divertito anche Umberto Eco.
L’offuscamento di senso critico era anche, tuttavia, il frutto della consapevolezza che in fondo uno come lui avrebbe potuto indulgere a una sperimentazione di quel genere, per quanto non fosse certo un frequentatore del genere fantasy. E poi, mi sono detto, sai le risate che si sarebbe fatto se uno scherzo del genere lo avessero fatto lui vivente, sai le battute che avrebbe lanciato alla volta degli amici che ci fossero cascati? Perché la sua allegria, il suo ottimismo, la joye de vivre che lo rendevano tanto simpatico e che travolgevano sempre i suoi interlocutori erano tali da finir col giustificare anche quell’estrema blague, quella che De André definirebbe “l’ombra di un sorriso – tra le braccia della morte”.
In effetti me lo ricordo sempre così: sempre sorridente, anche in casi nei quali il sorriso poteva costare un po’ di sforzo. Era una delle tante manifestazioni della sua proverbiale generosità. È vero che negli ultimi dieci anni, in questo senso, era un po’ cambiato: e non solo né tanto a causa del tempo che passava, dell’età che cominciava a pesare e della salute che dava qualche segno di cedimento. Il suo dolore profondo, che non lo abbandonava mai e che offuscava anche i suoi momenti più lieti, era legato all’assenza di Hanka. La moglie amatissima era scomparsa nel dicembre del 2004: un vuoto quasi inatteso per lui che, una decina di anni più anziano di lei, si era sempre semmai rattristato all’idea di doverla un giorno lasciar sola. Da allora, nei nostri non pochi incontri nella sua casa di Rue Thionville dalla quale ormai non usciva più, non ce n’è uno in cui mi ricordi ch’egli non ne abbia parlato.
Potrei cominciare le mie poche note sul Le Goff “storico e maestro”, mettendo da parte l’inevitabile Amarcord, da molti argomenti: eppure mi sembra che il modo più opportuno per avviarle sia proprio il suo splendido, struggente Avec Hanka, edito nel 2008 da Gallimard e con grande finezza tradotto nel 2010 per la Laterza da Valentina Parlato. Un libro autobiografico, certo. Un libro di ricordi. Perché no?, un libro d’amore. Sono molte, le sue opere che amo in modo particolare e che ho riletto più volte, a cominciare dai suoi due grandi ritratti di Francesco d’Assisi e di san Luigi: ma ogni volta che qualcuno mi chiede una lettura, una sola, per capire a fondo il Le Goff storico – e, badate, questo non è un paradosso –, immancabilmente consiglio questa.
Perché è da queste pagine in cui si parla d’incontri, di viaggi, di episodi quasi tutti lieti o comunque sereni, di tante personalità anche eccezionali incontrate, di politica e qua e là anche di religione, ovviamente di libri di ricerche e di convegni, che emerge limpido e straordinariamente impregnante il legame forte, profondo, inestricabile, tra l’amore per la vita e l’amore per la storia, tra esperienza scientifica e intellettuale da un lato e capacità umana d’intendere e di ascoltare se stessi e gli altri. Si può ben essere eccellenti professionisti e ineccepibili studiosi senza queste qualità: ma non si può essere davvero grandi. Lui lo è stato. E lo si notava sempre non già nelle solenni e impegnative occasioni, ma quando gli capitava di dover abbozzare una nuova ricerca, magari alla buona su un foglietto di carta a un tavolo di caffè, o di affrontare i problemi di un allievo che sembrava non farcela, o giudicare il lavoro di un collega che non lo aveva del tutto convinto.
Je ne serai jamais mandarin, disse una volta con una frase divenuta proverbiale. A dispetto della sua straordinaria notorietà (“Il più grande medievista del XX secolo”…: che vuol mai dire “il più grande?) non ha mai percorso una vera e propria “alta” carriera universitaria nel mondo francese che continua ad amare uniformi ricamate e decorazioni, non ha mai avuto una cattedra né pubblicato una solenne, ponderosa grande thèse. Diciamo la verità: non che disprezzasse tutte queste cose, magari in fondo la mancanza di certi riconoscimenti gli pesava. Solo che non era roba per lui; non erano cose che lo interessavano.
Amava il medioevo. Non si limitava a studiarlo, questo è il punto. « C’est vers le Moyen Âge, enorme et délicat, – fu’il faudrait que mon coeur en panne naviguât…»: aveva sul serio fatto suoi questi due versi celeberrimi di Verlaine, nei quali pur senz’ombra di residuo romantico si riconosceva. A condurlo a interpretare così bene il connotato di fondo della braudeliana Nouvelle Histoire, il rapporto tra storia e antropologia, era l’interesse permeato di passione per come la gente del “suo” medioevo (che, per “lungo” ch’egli lo abbia teorizzato, fin quasi a lambire l’Ottocento e magari in qualche caso ad arrivar oltre, era per lui quello “pieno”, sostanzialmente tra la fine del X e la metà del XIV secolo) concepisse il tempo e la vita, come potesse al tempo stesso vivere in un universo così concretamente e tangibilmente pieno di realtà metafisiche e immateriali – invisibilia, in tutte le possibili accezioni del termine – e al tempo stesso così fortemente, robustamente attaccato alla terra e ai valori più sanguigni e materiali.
Lo affascinava, e lo induceva alla sfida di comprendere, quella capacità di vivere contemporaneamente e integralmente – per dirla con le parole del titolo di uno dei suoi libri più noti – il Tempo della Chiesa e il Tempo del Mercante, di credere non solo in Dio e nelle corti divina e diabolica ma anche nell’intermondo meraviglioso delle fate e dei draghi, d’immergersi nell’immaginario mistico e cavalleresco e al tempo stesso di affrontare e vincere le foreste, le paludi, le brughiere e le distese marine, di guadagnare e d’idolatrare la ricchezza, il corpo fisico, perfino il ridere. Alla domanda di come questo equilibrio fosse possibile cercò di rispondere sin dalla fine degli Anni Cinquanta, pubblicando il suo “classico” saggio sugli intellettuali nel medioevo; continuò poi dirigendo in due occasioni altrettante équipes di suoi allievi e/o colleghi prima con L’uomo nel medioevo, quindi con Uomini e donne del medioevo; infine affrontando quello ch’era sempre stato forse il tema secondo lui nodale, il rapporto tra il tempo e la vita, tra Anno Liturgico e Calendario, nel suo studio su Giacomo da Varazze e la Legenda Aurea.
Ecco il suo effettivo sentire storico-antropologico, che mi sembra sia sfuggito a molti. La coscienza profonda, verificata attraverso lunghe e severe ricerche, dell’evidente prossimità e al tempo stesso dell’astrale lontananza tra il medioevo e quella che usiamo definire la “Modernità”. La lontananza e l’inconciliabilità – a dispetto dei tantissimi elementi continuistici delle numerose eccezioni, delle forti contraddizioni – fra un’età integralmente per quanto sotto alcuni aspetti contraddittoriamente (e “barbaramente”) cristiana e una di dubbio, d’incredulità e di disincanto; fra un tempo nel quale la persona non s’intende se non attraverso la comunità nella quale è inserita e uno nel quale si finisce con l’idolatrare individuo e individualismo; fra un’era che vive a proprio agio, come un pesce nell’acqua, tra visibilia e invisibilia e un’altra lacerata dall’opposizione tra un materialismo sempre più volgare e impietoso da una parte, la tentazione continua dell’irrazionalità e dell’irrealtà più sfrenate dall’altra. Per noi moderni e/o “postmoderni” il medioevo, al contatto del quale e per molti versi nel quale (fonti, documenti, monumenti, istituzioni, memorie, credenza, fantasie…) continuiamo a vivere, è presente fino all’ossessione, magari in tante forme di revival; eppure al tempo stesso è un insondabile, incomprensibile Altrove.
In questo senso, forse, il saggio-chiave di tutta l’opera legoffiana resta il grande studio su L’invenzione del Purgatorio. Quel ponte gettato tra i vivi e i morti, tra la vetta irraggiungibile della santità e la dannazione evitata per un soffio, fu una “invenzione” che permise di dominare e di controllare l’angoscia dell’esistere di una potenza rispetto alla quale le invenzioni scientifiche e tecnologiche che hanno consentito all’uomo moderno e contemporaneo di governare e di gestire la realtà – vincendo magari il bisogno, appagando la volontà di potenza, ma senza riuscire a salvarlo dall’angoscia di vivere un tempo finito, una corsa irreversibile verso il Nulla – rischiano per certi versi d’impallidire. È forse per questo che ci sorprendiamo talvolta a navigare verso il medioevo enorme e delicato. E allora possiamo affidarci a Jacques le Goff, nato nella marinara solare Tolone da una famiglia di vecchi marinai bretoni. È stato un buon timoniere. E, per me, un Maestro carissimo.
Forse non il più caro: nulla e nessuno potrà mai strapparmi dal cuore l’immagine di Ernesto Sestan. Ma certo quello che più mi ha aiutato; che mi ha insegnato l’allegra umiltà dell’insegnare in modo semplice a chi sa meno di te accettando serenamente magari il rimprovero, per questo, di colleghi più severi che ti vorrebbero sempre e soltanto cultore di scienza rigorosa ma senza curarti del po’ di effimero successo mediatico che ciò ti procura; che mi ha dato di più sopportando le delusioni che gli procuravo e qualche volta l’imbarazzo, probabilmente il fastidio, per certi miei eccessi non troppo politically correct che certo non apprezzava ma che pure rispettava se non altro per quello che gli pareva coraggio civico, senso di libertà (e che magari era solo imprudenza e avventatezza).
Non amo ricordarlo negli ultimi anni, dietro alla barricata dei libri sulla sua scrivania, smagrito e ormai quasi incapace di muoversi, immerso nella solitudine irrimediabile nella quale lo aveva lasciato scomparendo inaspettata, la sua amatissima Hanka. Lo ricorderò invece per sempre così, come in quel giardinetto della vecchia sede dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales il mattino dell’ultimo seminario dell’anno accademico 1978-79, in un glorioso e splendente sole parigino di primavera. È così che lo ricorda mia figlia Giovanna, allora dodicenne, sconsideratamente trascinata in quel tiaso di dotti e matti ragazzi guidati da un dotto e matto cinquantacinquenne. Quel signore alto e corpulento che rideva gioviale mentre – secondo la tradizione del fine-seminario, che comportava un rustico aperitivo – piluccava alternativamente da due grandi piatti una ciliegia e una fettina di salame secco. Jacques Le Goff, il piacere di vivere, la gioia dell’intelligenza.
Franco Cardini
Direttore editoriale think tank “Il Nodo di Gordio”
© RIPRODUZIONE RISERVATA