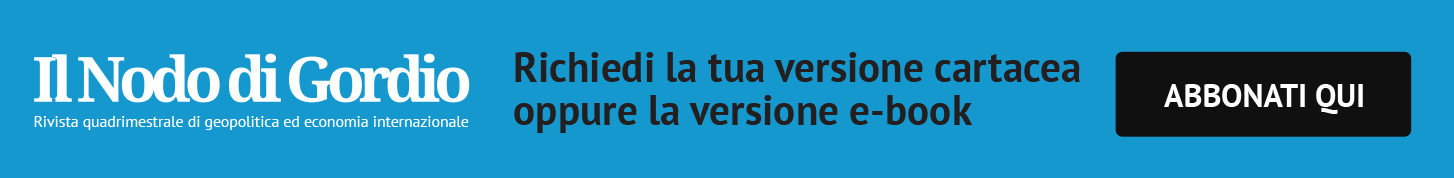Di Andrea Marcigliano
Apparentemente periferico rispetto all’Europa, ignorato o considerato dai più alla stregua di un remoto “paese esotico”, il Caucaso rappresenta, al contrario, uno dei punti critici della geopolitica mondiale. E non da oggi soltanto, ché fu una regione strategica già negli anni del cosiddetto “Grande Gioco”, nel conflitto appena velato che contrappose a lungo l’Impero Britannico e quello degli Zar in una complessa partita che aveva come obiettivo il controllo del “cuore del mondo”. “Cuore” di cui la regione caucasica rappresenta una delle vie d’accesso fondamentali e, al contempo, più difficili da dominare. Non fu un caso che, ancora nella seconda guerra mondiale, la Germania di Hitler lanciasse una delle sue linee offensive contro l’URSS proprio in direzione del Caucaso, cercando ( vanamente) di conquistarlo sia per le importanti ricchezze petrolifere del suo sottosuolo, sia soprattutto per la posizione strategica che riveste. Posizione dalla quale è possibile non solo controllare l’accesso al cuore della Russia e le comunicazioni tra questa e le vastità steppose dell’Eurasia, e di conseguenza i traffici tra l’area del Mar Caspio e quella del Mar Nero, ma anche incombere – da una posizione strategicamente dominante – su tutto il Golfo Persico e, di conseguenza, sul fulcro del Grande Medio Oriente. Durante la Guerra Fredda, naturalmente, il Caucaso era caduto in un sostanziale oblio. Consegnato all’egemonia sovietica, era divenuto un problema di esclusiva pertinenza di Mosca, mentre le Cancellerie di Washington e dell’Europa occidentale concentravano la loro attenzione su altri scacchieri strategici. Ma il crollo dell’URSS e l’implosione del suo impero, hanno forzatamente riportato l’area caucasica al centro delle strategie – e, di conseguenza, dei conflitti – del nuovo secolo. Una centralità che va ben al di là dell’attenzione risvegliata tra i media e l’opinione pubblica dalla “ questione cecena” e, soprattutto, dai recenti, tragici, fatti d’Ossezia; ché, per altro, sarebbe assurdo pretendere di ridurre la complessità della “questione caucasica” ad un semplice moto di insurrezione di popoli storicamente sempre riottosi ad essere soggetti al governo di Mosca. La questione dell’indipendentismo delle diverse etnie della regione e della loro aspirazione a separarsi dalla Russia è, certo, importante, come sottolinea Mattew Evangelista nel suo recente saggio The Chechen War, particolarmente interessante anche perché edito dal Brookings Institution, il think tank neoliberal che sta preparando le linee strategiche della politica estera di un’eventuale Amministrazione Kerry. Evangelista incorre, tuttavia, nell’errore (classico) che abbiamo visto essere già alla base della politica estera USA nei Balcani durante l’era Clinton: ridurre, troppo semplicisticamente, a “conflitti etnici” questioni ben più complesse e sottovalutare l’importanza geopolitica e culturale di determinate “tensioni”.
E se questo nell’area balcanica ha provocato degli errori di cui stiamo solo ora cominciando ad intuire la portata, potrebbe rivelarsi ben più pericoloso nel Caucaso, ove tra l’altro, gli USA hanno oggi dei fondamentali interessi. Interessi, al tempo stesso, strategici ed economici, ché la “sete” di combustibili fossili dell’economia americana e il rischio ( sempre incombente) di crisi nell’area petrolifera del Golfo, rendono essenziale per Washington il trovare fonti di approvigionamento alternative. E il petrolio ed il gas dell’area del Caspio rappresentano, appunto, una di quelle “riserve” su cui ormai gli americani pensano di dover far conto nel prossimo decennio. Riserve che, però, richiedono di essere “trasportate” a Occidente; di qui la costruzione della “pipeline” Baku – Tiblisi – Ceyhan e il progetto di altri oleodotti e gasdotti che passino attraverso il Caucaso georgiano e convergano poi sui porti del Mar Nero turchi ed ucraini. Linee, tutte, che vedono però tagliato fuori dal loro percorso il territorio russo, provocando la conseguente azione del Cremlino che è riuscito, negli ultimi mesi, a far rientrare Kiev nella propria orbita politco-economica, vanificando in parte i disegni statunitensi. E che, per sovramercato, ha colpito con impensabile durezza il colosso petrolifero Yukos che aveva instaurato dei rapporti preferenziali con le multinazionali del petrolio americane, riducendolo sull’orlo del fallimento; con il risultato di ricondurre all’”obbedienza moscovita” gli altri Grandi del petrolio del Caspio. E tuttavia la questione petrolifera è solo un indicatore del “conflitto” latente nell’area caucasica tra Mosca e Washington. Un “conflitto”, ovviamente, non guerreggiato, ma politico, economico, diplomatico…conflitto di servizi segreti, di lotte per il controllo e/o l’influenza su piccoli centri di potere locale, di sottili diplomazie d’altri tempi…A tutti gli effetti, la riproposizione dello “scontro” – che mai portò ad una guerra – lungo oltre due secoli tra Mosca e Londra; laddove, ovviamente, il ruolo che fu del British Rule è oggi del nuovo Impero americano, erede, a tutti gli effetti, della potenza “talassocratica” inglese. Talassocrazia che, per sua natura, tende al controllo politico delle “zone costiere” e al rafforzamento della loro sicurezza. Zone costiere cruciali, oggi come ieri, sono, ovviamente, quelle del Golfo Persico, dove gli USA stanno giocando una delle più complesse partite della loro storia. Assicurarsi le “spalle” e, al contempo, una risorsa energetica alternativa, è per Washington, quindi, vitale, ed il Caucaso si è fatto, di conseguenza, sempre più importante nelle strategie di Foggy Bottom e della Casa Bianca. Che ha investito tempo e risorse nel cercare di favorire il distacco progressivo da Mosca delle principali repubbliche ex-sovietiche dell’area ed il loro ancorarsi saldamente a politiche (ed interessi) convergenti con quelle americane. Esemplare il caso della Georgia, ove gli USA hanno pompato dagli anni ’90 ad oggi molti miliardi di dollari per favorire lo sviluppo della “democrazia” georgiana. Che significa, poi, in primo luogo cercare di aiutare il governo di Tbilisi nel “nation building”, ovvero nella costruzione di strutture politiche e sociali di tipo occidentale. Il “nation building” rappresenta una della “armi” più forti ed importanti nelle mani degli USA, un eccezionale strumento di penetrazione politica e culturale insieme. In Georgia, negli anni ’90, è stato utilizzato con molta intelligenza, e avendo, soprattutto, a disposizione tempo e campo libero. Anche perché Mosca, travagliata da mali endemici e priva, sotto Eltsin, di una forte direzione politica, era costretta a guardare e lasciar fare. Ma questo stato di cose non poteva durare in eterno, anche perché, per la Russia, il Caucaso è, a tutti gli effetti, il “giardino di casa”. Ovvero parte integrante del suo spazio geopolitico e settore cruciale, anzi vitale, dei suoi interessi. Perché, non dimentichiamolo, la ripresa dell’economia russa in questi ultimi anni – PIL intorno al 7% annuo, secondo solo a Cina ed India – è dovuta essenzialmente, se non esclusivamente, all’industria estrattiva ed all’esportazione di gas e petrolio. Era, quindi, solo questione di tempo perché il Cremlino cominciasse a reagire alla penetrazione statunitense nel Caucaso ( e, parallelamente, nell’Asia Centrale). Una reazione che, nel caso della (cruciale) repubblica di Georgia sta sempre più inverandosi attraverso il sostegno di Mosca alle diverse entità separatiste che rischiano di farla implodere. La Georgia è, infatti, una realtà molto complessa e composita. Come ‘d’altra parte, tutti gli “stati” caucasici. Al suo interno convivono etnie diverse per storia, lingua, cultura; e soprattutto alcune sue regioni sono tradizionalmente riottose – per usare un eufemismo – al governo di Tbilisi.
L’Ossezia del Sud, l’Abkhazia e l’Adjaria rivendicano la loro autonomia e, in prospettiva, indipendenza dalla Georgia, trovando in Mosca un appoggio per le loro rivendicazioni. Fino a che a Tbilisi è restato al potere Shevardnadze – già ministro degli esteri sovietico nell’era di Gorbaciov, poi indiscusso ras della nuova repubblica caucasica – si è mantenuto un certo, precario, equilibrio tra le aperture verso l’America e la necessità di convivere con il (potente) vicino russo. Ma la “rivoluzione delle rose” della scorsa primavera ha defenestrato la vecchia “volpe bianca” della diplomazia sovietica, portando al governo il “giovane” e soprattutto energico Mikheil Saakashvili, deciso a ricondurre all’obbedienza del potere centrale georgiano le province ribelli. E, al contempo, a spingere sull’acceleratore per portare sempre più Tbilisi nell’orbita statunitense; ad entrare, a tutti gli effetti, a far parte organica della nuova rete di alleanze su cui Washington punta per costruire e mantenere un nuovo ordine globale. Inoltre il caso Georgia viene ormai considerato dai politologi statunitensi come un esperimento fondamentale per dimostrare che il modello politico-economico liberal-democratico – ovvero Occidentale – è compiutamente esportabile anche in altre parti del globo. Una conferma sempre più necessaria per i fautori di quel “messianismo democratico” – o, se si vuole, “realismo idealistico”- che influenzano oggi, in misura considerevole, le politiche della Casa Bianca. E tuttavia questo non può non portare ad una tensione – nell’area – con Mosca; anche perché Saakashvili si è spinto sino a minacciare/paventare un vero e proprio, imminente,conflitto armato con la Russia nel caso questa persistesse nel suo appoggio ai “ribelli” osseti ed adjari. Una partita, come si può intuire, estremamente complessa. Anche perché sul suo svolgimento inferisce la presenza di un altro “attore globale” oltre a Mosca e Washington. La crescita, in tutto il Caucaso, dell’influenza e della “rete” dell’islamismo radicale. Un terzo giocatore che sta scompaginando le carte e forzando a”strane” alleanze.1.continua