 Intervistata dal Nodo di Gordio, Susan Dabbous, giornalista italo-siriana, collaboratrice di Avvenire, l’Espresso e Rainews24, illustra l’evoluzione degli scenari geopolitici tra Siria, Libano, Turchia e Russia e il ruolo dei “ribelli” nell’ipotesi di un “dopo-Assad”..
Intervistata dal Nodo di Gordio, Susan Dabbous, giornalista italo-siriana, collaboratrice di Avvenire, l’Espresso e Rainews24, illustra l’evoluzione degli scenari geopolitici tra Siria, Libano, Turchia e Russia e il ruolo dei “ribelli” nell’ipotesi di un “dopo-Assad”..
In caso di un crollo del regime di Assad – che molti osservatori danno per imminente/inevitabile – quali potrebbero essere i riflessi sugli equilibri della regione? In particolare, che cosa potrebbe questo comportare per il Libano e per Hezbollah ?
Va chiarito cosa si intende per immediato. È da due anni che, purtroppo, si susseguono analisi e dichiarazioni su un’imminente fine del conflitto quando i fatti dimostrano che non è così. L’unica previsione ad essersi avverata è quella del direttore d del Think Tank Carnegie di Beirut, Paul Salem, che nel maggio del 2011 disse chiaramente: quella siriana non è una rivolta che seguirà l’esito delle altre primavere arabe. Quella siriana sarà una guerra civile a bassa intensità che durerà per anni. Le cause sono oggi molto note, il coinvolgimento diretto dell’Iran e della Russia, quest’ultima con potere di veto nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, hanno di fatto trasformato la Siria in un terreno dove ogni potenza regionale tenta di portare avanti i propri interessi.
Va ricordato, invece, per dovere di cronaca (perché dopo due anni è anche lecito dimenticarlo) che la rivolta siriana, così come quella tunisina, egiziana, yemenita e libica ha avuto inizio con proteste pacifiche in cui si chiedeva la caduta di un regime non eletto democraticamente e in carica da decenni.
Rispetto agli altri paesi arabi però la Siria si trova in una posizione geografica particolare in cui il Libano si sviluppa come una piccola appendice al suo interno. Uno Stato grande più o meno come il Lazio diviso in una miriade di confessioni religiose. Tra queste, l’Islam sciita, rappresentato politicamente e militarmente da Hezbollah, rivendica un peso più importante all’interno della vita del Paese, finora garantito dal sostegno muscolare della Siria di Assad. Inutile ricordare quindi che la caduta di Assad porterebbe a uno strutturale indebolimento del Partito di Dio, cosa più interessante è invece provare a ipotizzare come questo partito-milizia stia al momento iniziando a gettare le basi per la sua sopravvivenza. Hezbollah ha infatti sufficienti risorse economiche e militari per sopravvivere alla fine del regime di Damasco, il problema è solo capire per quanto. Gli aiuti da parte dell’Iran e l’Iraq sciita dovrebbero trovare altre vie o aprire un varco (insospettabile ma possibile) all’interno della nuova classe dirigente siriana che sarà tutt’altro che omogenea.
In che misura le forze che guidano la rivolta siriana sono o rischiano di essere egemonizzate a gruppi islamici di formazione salafita o dai Fratelli Musulmani? E quale sarà il destino della minoranza alawita – nonché di quella cristiana – nel caso dell’affermazione di questi?
Possiamo partire da un dato: l’ultimo vertice militare dell’Esercito siriano libero tenutosi ad Antalya, in Turchia, il 7 dicembre scorso ha visto eleggere il neo leader del Els, Salim Idris da 300 disertori di cui i due terzi erano vicini ai Fratelli Musulmani siriani e ai salafiti. Si tratta di una percentuale rappresentativa che si può generalizzare senza alcuna forzatura nel resto del Paese: la Siria è al 70 per cento sunnita, all’interno di questa comunità la maggior parte delle persone in tempi di pace era su posizioni decisamente conservatrici, in tempo di guerra invece il fondamentalismo islamico è diventato per molti o una ragione di vita o un modo per sfruttare il sacrificio degli altri per portare avanti una battaglia che i generali sanno essere ancora lontana dalla fine.
Ciò detto vanno fatte delle distinzioni: I fratelli musulmani hanno un’organizzazione internazionale storica alle spalle su cui fare affidamento, i gruppi salafiti appartengono a singole personalità carismatiche religiose, gli sheikh, che come nel caso del dei movimenti di protesta europei antisistema, parlano al cuore della povera gente con un linguaggio molto semplice. Spesso gli stessi leader, nonostante il titolo di sheikh, almeno in Siria, hanno uno scarso background culturale.
La minoranza alawita è stata per secoli discriminata per via del suo esoterismo religioso lontano dalla lettura ortodossa del corano, sia dall’impero ottomano che dagli arabi. Non a caso la scelta di vivere in luoghi impervi sulle montagne nella regione costiera di Latakia ha rappresentato per loro una delle poche vie di salvezza. Il colpo di Stato di Hafez Assad (padre dell’attuale presidente Bashar) ha significato per questa comunità fino a quel momento emarginata e poverissima, un momento di riscatto. L’avanzata sociale degli alawiti (avvenuta con il loro inserimento in ogni singolo apparato statale) ha creato un profondo shock nell’élite sunnita. La situazione odierna è molto complicata, da un lato c’è un obiettivo rischio di genocidio a danno di questa minoranza, dall’altro si tenterà probabilmente di ricostruire uno Stato alawita, sulle ceneri di quello esistito negli anni trenta, con scarse probabilità di durata, proprio come quello voluto dalla Francia durante il suo mandato in Siria. In una simile ipotesi la Russia potrebbe vedersi garantito il suo porto militare a Tartus, zona che ricadrebbe in questo ipotetico Stato.
I cristiani sono invece da sempre parte viva del tessuto sociale siriano e non sono legati a regioni specifiche: sono concentrati per lo più ad Aleppo e Damasco in cui giocano un ruolo importante nell’economia sia sul piano industriale (nel Nord) che in quello commerciale. I loro interessi sono così forti da aver inibito finora una fuga di massa come avvenne negli anni scorsi per i cristiani in Iraq. Nonostante il generalizzato appoggio al regime di Assad, infatti, non va dimenticato che molti esponenti di spicco dell’opposizione sono dei cristiani, alcuni dei quali, come George Sabra e Michel Kilo, erano noti per le loro posizioni già prima delle rivolte del 2011.
Sempre parlando delle forze “ribelli”, quale è l’influenza del Qatar e dei Sauditi su queste forze? E quale ruolo sta esercitando la Turchia di Erdogan?
Il sostegno ai ribelli è una partita che, almeno sul piano dell’armamento, stanno giocando due attori principali: il Qatar e l’Arabia Saudita, ma non senza antagonismi. I due Stati petroliferi infatti sono in perenne competizione da quando Doha ha deciso di sfidare l’egemonia regionale saudita non solo sul piano politico-economico ma anche in quello culturale, settore in cui ha praticamente già vinto. “Aiutare i fratelli siriani” nella loro jihad contro un presidente alawita (e quindi eretico) è per molti predicatori che trovano spazio e voce in questi due paesi il dovere di ogni buon musulmano, così partono le collette e così arrivano i soldi ai piccoli gruppi di combattenti. Altra cosa sono invece i grandi battaglioni dell’Els i cui generali hanno rapporti diretti con uomini d’affari e venditori di armi che si dedicano a questo business prestando oggi qualcosa che domani chiederanno in dietro. La Siria pur non essendo un paese particolarmente ricco ha molte cose che mancano ai paesi del golfo: lo sbocco sul Medirerraneo, l’agricoltura e l’industria leggera. Elementi che non sfuggono certo neanche alla Turchia il cui appoggio politico e logistico ai ribelli ha preso ormai il gusto di una battaglia ideologica. Senza dimenticare che, dopo l’ennesimo diniego, la Turchia ha smesso di guardare all’Europa decidendo di rafforzare il suo ruolo in Medio Oriente.
Per Mosca la Siria è sempre stato un alleato fondamentale e la garanzia di uno “sbocco” sul mediterraneo. Come vedono i russi la fine del regime amico degli Assad? E stanno cercando nuovi referenti interni per il futuro?
Anche in questo caso la diplomazia si muove su piani, da un lato il sostegno incondizionato all’alleato Assad, dall’altro l’apertura al dialogo con l’opposizione siriana, buona parte della quale ha vissuto o studiato a Mosca. La capitale russa ha rappresentato infatti un luogo fondamentale per la formazione dell’intelligentia siriana. Ciò detto, la posizione russa non è affatto semplice, oltre alla questione del porto c’è la condivisione della tecnologia militare (compreso l’arsenale chimico) costruita in oltre 40 anni di ininterrotte relazioni. Inoltre al Cremlino come alla Casa Bianca sulla Siria si è palesata la stridente visione delle maggiori personalità politiche divise in pro e anti cambiamento. Si è sentito, in più di un’occasione, un Putin irriducibilmente pro Assad contro un Medvedev aperto al “dopo”. A Washington Obama frenava l’armamento ai ribelli mentre la Clinton era su posizioni più interventiste. Col neosegretario Kerry si apre sicuramente uno scenario molto interessante anche alla luce dei suoi eccellenti rapporti con Israele. Finora parte dell’immobilismo internazionale in Siria è stato analizzato, in parte, come frutto dell’impreparazione di Tel Aviv ad affrontare un nuovo scenario. Nel lungo periodo però il conflitto siriano potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang, visto il dilagarsi della retorica antisionista tra gli jihadisti in Siria. “Dopo Assad combatteremo Israele”, dicono oggi. Una frase che solo fino a un anno fa sarebbe apparsa totalmente fuori contesto.
Susan Dabbous
Giornalista professionista italo-siriana, Susan Dabbous ha studiato relazioni internazionali all’università di Roma La Sapienza e alla Carlos III di Madrid. Consegue la laurea nel 2006, anno in cui inizia ad occuparsi di giornalismo ambientale per poi dedicarsi a temi sociali e politiche europee soprattutto da Bruxelles e Parigi. Nel 2008, a Washington, segue l’ultima fase della campagna elettorale americana e l’insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca. Dal 2011 copre gli accadimenti in Siria viaggiando spesso in Turchia e in Libano. Attualmente basata a Beirut collabora con diverse testate italiane tra cui Avvenire, l’Espresso e Rainews24.


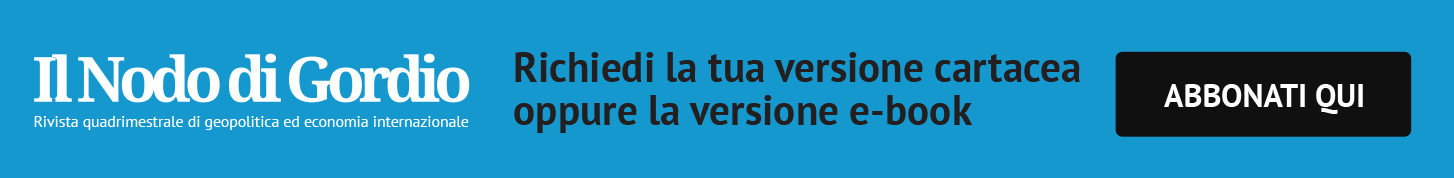















Comments 1